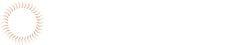Il diritto all’oblio risponde all’esigenza che ognuno di noi può avere di far dimenticare a tutti la propria identità. Nella sua accezione più ampia è, infatti, una modalità attraverso la quale si esplica il nostro diritto all’identità personale: si oblia (si chiede di obliare) ciò che riteniamo non debba essere più parte della nostra identità personale.
Il diritto all’oblio può essere praticato attraverso la richiesta di rimozione delle informazioni personali che ci riguardano dalla loro pubblica circolazione. Per questo è equiparabile al diritto alla cancellazione, anche se, in realtà, sono diritti diversi tra loro: la pretesa di cancellazione delle nostre informazioni personali è una conseguenza dell’esercizio del diritto all’oblio; si può pretendere la cancellazione di dati personali anche per presupposti diversi.
Diritto all’oblio vs. diritto alla memoria
Gli esseri umani vivono da sempre una evidente contraddizione rispetto a ciò che vogliono che tutti sappiano di sé stessi (memoria di sé) e ciò che preferiscono resti segreto (che si oblii).
Il tema del diritto alla memoria viene magistralmente espresso in poche righe da Francesco Pizzetti (cfr. Privacy e il Diritto Europeo alla Protezione dei Dati Personali, Giappichelli, 2016):
“Da un lato, essi aspirano all’immortalità e, sapendo di non poterla avere, cercano di lasciare il più a lungo possibile memoria di sé come unico modo per prolungare la propria vita, o meglio il ricordo nel futuro del fatto che essi sono esistiti, e di ciò che hanno realizzato.”
“All’opposto, ogni persona umana ha anche il terrore che ogni atto negativo compiuto nel corso della propria esistenza possa essere ricordato per sempre, o almeno fino a quando è in vita e lo sono quelli che ne hanno memoria.”
Diritto all’oblio vs. diritto di cronaca
È con il diritto all’informazione che il diritto all’oblio si scontra in maniera decisamente più evidente, ovvero con il diritto di informare (diritto di cronaca) ed il diritto ad essere informati. Informare su fatti relativi ad un individuo, fornendo al contempo informazioni personali dello stesso, nel rispetto dei tre fondamentali parametri 1) dell’interesse pubblico, 2) dell’attualità (informare quando il fatto si verifica) e 3) della veridicità (fornire informazioni corrispondenti al vero), è la fattispecie più evidentemente afferente al diritto all’oblio.
Diritto all’oblio vs. libertà di manifestazione del pensiero
Ogni individuo gode del diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo. Libertà che, con gli strumenti della odierna società dell’informazione, consentono a chiunque, quindi non solo ai “giornali”, di poter rendere pubbliche informazioni sugli individui. Basti pensare alle migliaia di foto e video privati, anche a sfondo sessuale, diffusi, scambiati e pubblicati quotidianamente tramite WhatsApp, Facebook e YouTube, pubblicazioni che hanno portato anche, in alcuni tragici casi, al suicidio di chi ha preteso, senza successo, l’oblio.
Che significato assume oggi il diritto all’oblio
Il diritto all’oblio può storicamente coincidere con la nascita del diritto alla privacy ed alla riservatezza, ovvero con il diritto di essere lasciati in pace concepito da Warren e Brandeis nel 1890. Senza dubbio è emerso nell’era precedente all’avvento del Web, noto come “oscurità pratica” riferibile a dati fisici che erano “praticamente oscuri” per la impossibilità di accedervi. L’oscurità pratica arrivò per la prima volta nel 1979, quando alcuni giornalisti cercarono documenti in possesso dell’FBI di un uomo chiamato Charles Medico, le cui attività familiari presumibilmente avevano legami con il crimine organizzato.
Ma è con il World Wide Web, i Social Network e, in generale, le reti di comunicazione elettronica, che il diritto all’oblio acquisita in tempi recenti un significato estremamente più profondo e dirompente. Pretendere oggi che le proprie informazioni personali vengano sottratte alla pubblica circolazione non è agevole come poteva essere in passato, quando si poteva pretendere che le informazioni che ci riguardano non venissero ristampate, essenzialmente su carta, e diffuse ulteriormente.
La prospettiva oggi è totalmente diversa. Nel mondo digitale, caratterizzato dallo “sharing” continuo di contenuti (mossi dall’adagio “If you experience something – record it. If you record something – upload it. If you upload something – share it.”), non si tratta solo di impedire che permangano disponibili le nostre informazioni personali pubblicate dalla fonte originaria ma, piuttosto, far eliminare anche le successive ripubblicazioni delle stesse da parte di terzi soggetti.
In altre parole, la problematica più rilevante oggi non è relativa alla difficoltà di cancellare una notizia o una foto o un video pubblicati dalla fonte originaria ma alle ripubblicazioniche permangono sempre accessibili. Per questo motivo, la riflessione da fare oggi, per far salvo il diritto all’oblio, è su quanto può permanere pubblicamente disponibile una informazione online, prescindendo dal tempo trascorso dalla prima pubblicazione, che potrebbe aver fatto perdere alla notizia anche attualità e interesse pubblico.
La memoria, nel mondo fisico e analogico, è strettamente connessa ai limiti che lo strumento che la custodisce possiede per mantenerla nel tempo. Per quanto tempo possiamo ricordare una informazione? Quanto è semplice condividerla con altri? Quanto può farlo la carta? Nel mondo digitale e di Internet, invece, le informazioni possono essere memorizzate, duplicate e condivise con estrema semplicità, con la conseguenza che tutte le informazioni permangono, non ci sono esigenze di selezione, le memorie al silicio sono pressoché illimitate e, nel Cloud, non abbiamo contezza concreta di chi e dove ha memorizzato, duplicato, indicizzato e pubblicato le nostre informazioni.
Fonte: AgendaDigitale.eu